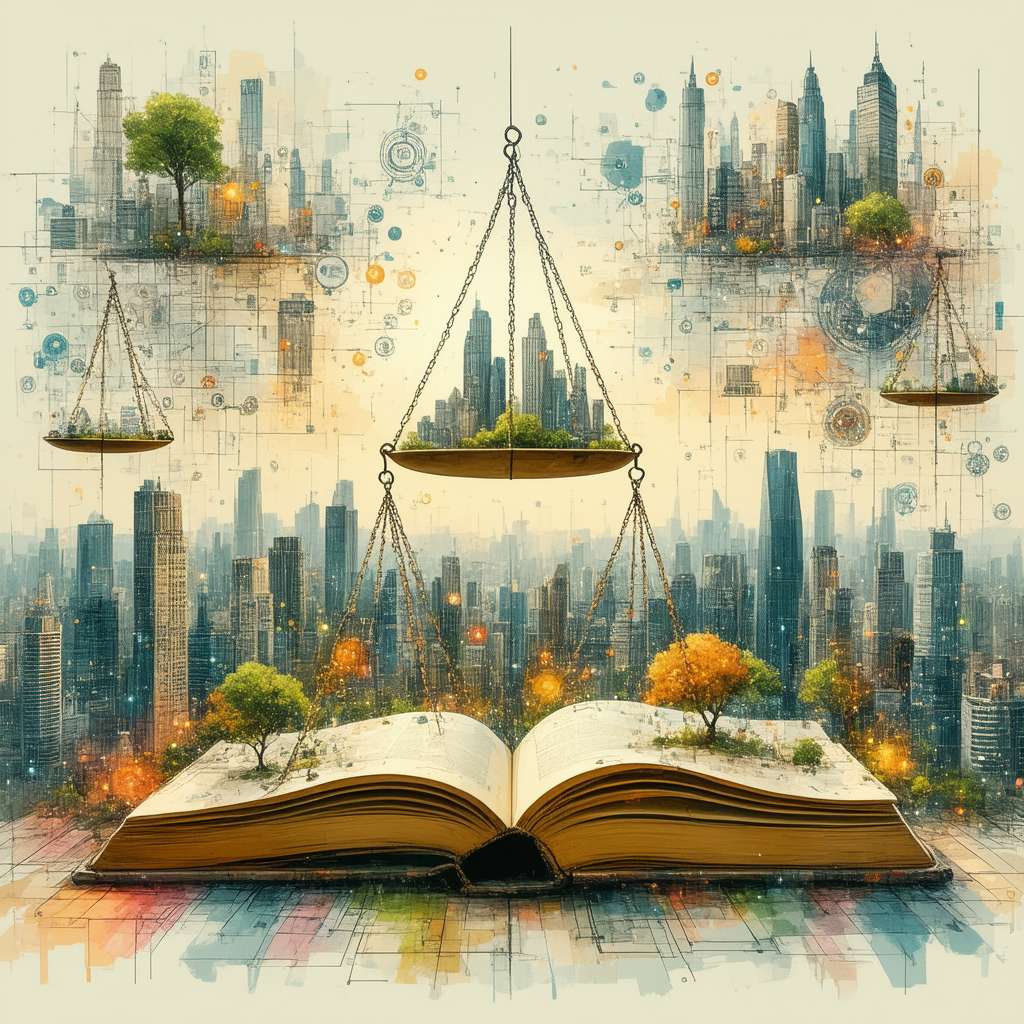E-Mail: [email protected]
- Byung-Chul Han critica il neocapitalismo attraverso le sue ultime due opere pubblicate da Einaudi nel 2024 e 2025.
- La crisi della narrazione esplora la perdita delle grandi narrazioni e la loro sostituzione con lo storytelling commerciale.
- Contro la società dell’angoscia analizza come l’angoscia sia usata per mantenere lo status quo e come la speranza possa offrire una via d’uscita.

Byung-Chul Han pone ulteriori due tasselli alla sua critica totale nei confronti del neocapitalismo contemporaneo, e lo fa con due volumi editi in meno di un anno di distanza l’uno dall’altro da Einaudi. Ne La crisi della narrazione. Informazione, politica e vita quotidiana, pubblicato nel 2024, il filosofo coreano riprende concetti che furono di Walter Benjamin e Max Weber capaci, più di un secolo fa, di fornire una lettura concreta della cosiddetta “perdita del centro” che ha segnato l’avvento della contemporaneità.
La perdita dell’aureola, lo shock, il disincanto traducono la fine delle grandi narrazioni che avevano fondato il mondo sin dall’antichità, dandone senso e consistenza, e introducono l’avvento dell’età della tecnica dove ogni cosa viene consumata nell’attimo del suo funzionamento. Han mostra con estrema lucidità come le narrazioni siano all’origine dell’atto stesso del vivere e come esse siano (o meglio siano state) capaci di sanare, curare, ri-generare l’uomo che, in quanto tale, si caratterizza come essere narrans.
Neocapitalismo e storytelling secondo Byung-Chul Han
La digitalizzazione – ribadisce Han – è una funzione utile all’ideologia dominante, coi suoi touch screen che ci rendono incapaci di esperire il tu, l’altro. In sostanza, la perdita della capacità di narrare ha portato alla ipertrofia dell’informazione che «si consuma nell’istante della sua novità». La sua caratteristica infatti è lo storytelling, più adatto ai canoni del moderno neoliberalismo, con i suoi dogmi dell’efficienza, del farsi da sé, del marketing che dà valore a cose che non lo hanno. Lo storytelling, appunto perché è votato al commercio, non è altro che un «vendere storie» che «non porta con sé la capacità di trasformare il mondo». E allora lo shock, con cui Benjamin descriveva, a proposito di Baudelaire, l’impatto con la realtà, diventa l’ossessione per i like, in un setting incapace di creare comunità, perché solo in grado di ripetere tautologicamente e impropriamente la parola “io”.
- 🌟 Un'analisi illuminante sul fallimento delle grandi narrazioni......
- 👎 Non sono d'accordo: Han esagera nella sua critica......
- 🤔 E se lo storytelling fosse il nuovo linguaggio di libertà?......
Un rimedio contro la società dell’angoscia

Se il primo volume si chiude con l’esortazione a riprendere il narrare, capace di creare comunità, l’ultimo, Contro la società dell’angoscia. Speranza e rivoluzione, pubblicato nel 2025, sembra più propositivo e appassionato. A partire da una analisi dell’angoscia, e del clima attuale di perenne crisi e ansia, tutti funzionali al neocapitalismo, Byung-Chul Han si sofferma sul fatto che tali predisposizioni d’animo – oltre a essere nemici di quanto è squisitamente umano – sono un ostacolo al compimento della democrazia. E questo perché tendono a isolare, a trasformare il vivere in un sopravvivere, rendendo l’altro nemico. «Angoscia e libertà si escludono a vicenda» scrive Han, poiché la prima ci sottrae dal futuro privandoci del piacere della speranza, in virtù della quale l’uomo può immettersi in un cammino e desiderare il futuro.
Il filosofo coreano si guarda bene dal confondere la speranza con l’ottimismo, poiché quest’ultimo risulta cieco al possibile, dato che a esso non manca nulla.
Il vero significato della speranza
La speranza, viceversa, è apertura assoluta all’altro e al “venturo”, poiché è attenzione al già e non ancora. Citando Gabriel Marcel, Han non ignora che sperare significa «far credito alla realtà». Anzi, ancor di più: dare credito alla realtà. Sperare è un atto del pensare e, in quanto tale, introduce a una conoscenza integrale del mondo, poiché il pensare è anche qualcosa di corporale, c’entra con il corpo, con le sue emozioni, con le vibrazioni del sentire. Per questo, scrive Han, l’intelligenza artificiale può essere intelligente, appunto, ma non potrà mai pensare e, pertanto, potrà pescare su quanto è già noto, senza avere la capacità di “incorporare” l’intelligenza in un pensiero puro.
Sperare è per Han un atto assolutamente rivoluzionario perché, diversamente dall’angoscia, non appartiene al «vocabolario capitalista». Chi spera, non consuma, ma si proietta in possibili mondi migliori. Anche in questo volume Han dimostra di possedere una vasta cultura. In tratti rapidi, come è nel suo stile, riprende una pletora di filosofi e letterati (da Scheler a Heidegger ed Hegel, da Camus alla Harendt, da Marcel a Bloch) per ottenere una definizione piena e compiuta della speranza, smontando eventuali riduzioni che di essa sono state fatte nel tempo.
Un inno in un mondo alla deriva
È innegabile per Han che «la speranza è in cerca di salvezza» e che essa è connessa con fede e amore. Una triade in grado di ridonare senso a un “esser-ci” sempre più abbandonato a sé stesso e alla deriva, capace al massimo di pensieri positivi che non sono altro che il risvolto del pessimismo. Entrambi hanno in comune l’inazione e l’inerzia, incapaci, come sono, di dare vigore al futuro, di parlare e fondare un futuro desiderabile in sé. L’ultima fatica di Han è forse una delle sue opere migliori, un inno alla speranza come atto squisitamente ragionevole, in grado di generare semi di umanità in un mondo sempre più alla deriva e schiavo di paradigmi che hanno come fine ultimo quello di creare isole nel mare della incomunicabilità.
Per orientarsi fra testo e contesto
Byung-Chul Han non è nuovo a questo genere di riflessioni. Già in opere precedenti, come La società della stanchezza, aveva denunciato lo stato di esaurimento psicologico generalizzato prodotto da una società iperattiva, in cui l’eccesso di positività e produttività strangolavano l’equilibrio mentale. In un modo simile, i saggi in esame suggeriscono che il recupero della narrazione autentica e la coltivazione della speranza potrebbero essere le chiavi per ritrovare l’umanità perduta. Han ci invita a riflettere su come le narrazioni abbiano tradizionalmente generato senso e su come, nel contesto contemporaneo, riscoprire una dimensione collettiva del vivere possa favorire la nascita di nuove forme di solidarietà e coesione sociale.